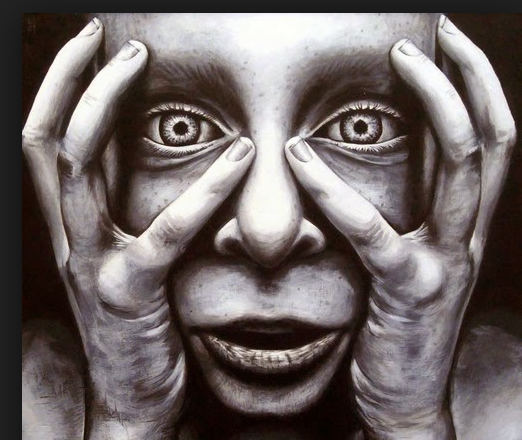Questa settimana (domenica) si è svolta a Pisa l’assemblea nazionale dei collettivi antipsichiatrici italiani. Si tratta di gruppi autorganizzati e associazioni (all’incontro presenti quelli di Pisa, Messina, Milano, Bologna, Perugia, Reggio Calabria, Padova, Verona e Torino), nati oltre dieci anni fa per combattere gli usi ed abusi della psichiatria, quali la deterrenza, la repressione e la dipendenza farmacologica. L’obiettivo dichiarato è «tirare fuori la gente dal Sistema psichiatrico nazionale e limitare i Trattamenti sanitari obbligatori». Detto così potrebbe sembrare uno slogan ma stanno parlando di un problema serio e concreto che già coinvolge milioni di cittadini, visto che negli ultimi cinquant’anni il numero di persone diagnosticate come psicotiche sulla base del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (Dsm) è quintuplicato. Negli Stati Uniti assume farmaci antidepressivi il 10% della popolazione adulta, spendendo 10 miliardi di dollari. Eppure le indagini epidemiologiche indicano che solo 1/3 di quelli che presentano una depressione grave sono in terapia: gli altri sarebbero quindi trattamenti inappropriati, che avrebbero avuto un esito positivo anche senza alcun intervento farmacologico.
L’Italia ha imboccato la stessa strada. «Il problema e l’orrore della psichiatria – spiegano gli animatori dei collettivi antipsi – è trasformare le persone che non vogliono essere curate in pazienti. Alla base dell’antipsichiatria c’è viceversa proprio la possibilità di rifiutare le cure. Aiutare queste persone a riprendersi in mano il potere di decidere per loro stessi e tornare liberi di scegliere consapevolmente».
Questi collettivi mettono di conseguenza in discussione quelle che chiamano «pratiche di esclusione e segregazione» e gli «effetti spesso nefasti che questa scienza del controllo produce nella nostra società». Ma si battono anche per rendere noti gli elevati interessi economici dati dalla costante vendita di nuovi farmaci destinati a malati, immediatamente trasformati dal Sistema psichiatrico nazionale in pazienti con farmaci da prendere ogni giorno, a volte per tutta la vita, sulla base delle indicazioni che vengono date dai servizi di salute mentale. Per farlo, oltre a denunciare le violenze e gli abusi della psichiatria, informano anche sui farmaci e sui loro effetti collaterali. Molti di questi forniscono inoltre, a chi lo richiede, anche il supporto legale e un aiuto concreto su come uscirne.
Il dibattito è del resto aperto, anche all’interno dello stesso mondo psichiatrico, con tanti medici “pentiti” o quanto meno critici sull’attuale tendenza. Il manuale Dsm è arrivato alla quinta edizione. Considerato dal settore come una “Bibbia”, orienta le ricerche delle case farmaceutiche e soprattutto è il testo sul quale i tribunali basano le loro sentenze. Pubblicato negli Usa nel maggio 2013, in Italia un anno dopo, contiene un numero di disturbi mentali pari a tre volte quello della prima edizione del 1952 che ne riportava 128. Per non parlare del fatto che la metà degli psichiatri al lavoro nella stesura di questa ultima edizione del Dsm, tra il 1989 e il 2004 erano ricercatori o consulenti delle società farmaceutiche. E, guarda caso, si tratta proprio di quelli che nel manuale hanno curato le sezioni sui disturbi dell’umore e sulle psicosi, che in quegli anni si sono accompagnate all’impennata nelle vendite di farmaci considerati “appropriati”.
Fabrizio Starace è uno psichiatra alla guida del Dipartimento salute mentale e Dipendenze patologiche dell’Azienda unità sanitaria locale (Ausl) di Modena. Anche lui denuncia il pericolo che «il Dsm V, moltiplicando le categorie diagnostiche, aumenta il rischio di medicalizzazione e di sovra-prescrizione farmacologica immotivata». Gli fanno eco altri suoi colleghi, quali Francesco Scotti, psichiatra e psicoterapeuta ad indirizzo analitico, già responsabile dei servizi psichiatrici di Perugia, nonché autore di numerose pubblicazioni sull’argomento e ricerche in psichiatria fenomenologica nella Clinica universitaria di Roma. Oppure Ernesto Venturini, psichiatra ed ex direttore del Dipartimento di salute mentale di Imola, già collaboratore di Franco Basaglia a Gorizia e Trieste. Entrambi fanno notare come l’aumento del disagio psichico stia provocando nei servizi psichiatrici «il rischio di una crescente spersonalizzazione dei processi di diagnosi e cura e il sistematizzarsi di questo disagio nel concetto di malattia». Ma soprattutto come il ricovero ospedaliero sia tornato a essere centrale nell’economia dei servizi psichiatrici, riproducendo logiche repressive: «Nei Servizi psichiatrici di diagnosi e cura (Spdc) le porte sono chiuse e si operano sempre più contenzioni fisiche, inoltre la ridotta presenza di servizi aperti 24 ore testimonia la debolezza strutturale della nuova organizzazione, che non si costituisce come credibile ed egemonica alternativa alle logiche custodialistiche».
Il risultato di questa situazione è che, laddove le alternative statali latitano, arriva la supplenza dei gruppi autorganizzati. Anche perché se da un lato la legge italiana parla di trattamenti sanitari volontari, il rifiuto delle cure è possibile soltanto nel caso in cui si sia giudicati capaci di intendere e di volere. L’ago della bilancia si muove proprio su questo piano. Nel nostro Paese un soggetto è considerato paziente, quindi malato, se ne è consapevole e se i medici lo considerano tale. «Il problema è che per gli psichiatri siamo tutti malati, come del resto vogliono le case farmaceutiche, che lucrano e speculano su questo ambito, anche grazie all’elevata dipendenza che danno questi farmaci», continuano i collettivi.
Così a partire dagli anni Ottanta sono stati messi a punto diversi metodi per aiutare queste persone, che vanno al di là dei farmaci, molti dei quali avrebbero ottenuto risultati persino migliori secondo i promotori. All’assemblea un ragazzo sardo ha raccontato la sua storia: dopo 1 anno di comunità e ben 18 anni di farmaco, ora è riuscito a dimezzarlo restando però tuttora un malato mentale, nonché paziente, “parcheggiato” e inattivo, visto che subito dopo la diagnosi gli hanno immediatamente dato il 100% di invalidità con tanto di pensione.
C’è poi il problema dei Trattamenti sanitari obbligatori (Tso). Sulla carta i parametri per poterlo praticare sono soltanto tre: alterazioni psichiche tali da richiedere interventi terapeutici urgenti, rifiuto delle cure e nessuna alternativa al ricovero ospedaliero. Ma sono stati registrati diversi abusi, come ad esempio a Milano, dove è stato condotto addirittura un Tso programmato, che con l’urgenza e l’emergenza del momento sembra quindi aver ben poco a che fare.
Infine la questione degli Ospedali psichiatrici giudiziari (Opg), gli ex manicomi criminali, nei quali finisce come misura di sicurezza chi nell’ambito di un processo penale viene prosciolto per incapacità di intendere e di volere, ma internato per motivi di sicurezza, o chi, una volta entrato in carcere, mostra segni di squilibrio, o ancora i seminfermi.
Strutture, spesso fatiscenti, dove sovente è l’arbitrarietà a farla da padrone e la cura diventa la pena senza alcun termine finale. La legge 81 del 30 maggio 2014, come già avvenne per i manicomi grazie a Basaglia nel 1978, ha decretato la chiusura dei sei Opg (Aversa, Barcellona Pozzo di Gotto, Castiglione delle Stiviere, Montelupo Fiorentino, Napoli e Reggio Emilia). Vi sono internate circa 700 persone e continuano nuovi ingressi. Il codice penale invece non è cambiato. Se non nel nome. I sei Opg diventeranno quindi 20 Residenze per l’esecuzione di misure di sicurezza (Rems). Una per Regione. Stavolta la misura di sicurezza non potrà superare la reclusione massima prevista per il reato in questione. Ci saranno poi dei percorsi e programmi terapeutici individuali, affidati ai Dipartimenti di salute mentale delle Asl. Se l’esito dovesse essere giudicato negativo, per quelle persone si riapriranno le porte delle Rems.
«La modalità di intervento e la logica restano le stesse in quanto si ripropongono gli stessi meccanismi che portano le persone a finire in carico alla psichiatria sul territorio per tutta la vita, portandoli fuori casa, in strutture dedicate e strappandoli dal loro contesto», dicono i collettivi. «Chiediamo viceversa l’abolizione della pericolosità sociale così da poter intervenire direttamente nell’ambito del loro ambiente familiare e del loro contesto di riferimento, ponendo sempre alla base di tutto la libera scelta individuale».